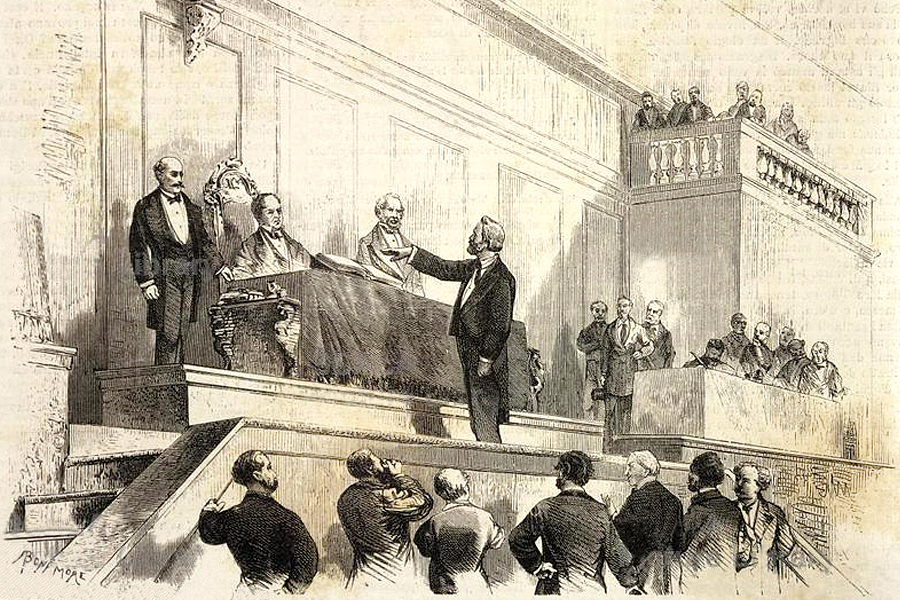L’altra opera di Giuseppe Verdi è certamente quella che lo vide impegnato, per tutta la vita, in una intensa attività quale proprietario terriero innovatore e testimone delle sorti dell’Italia Unita legate allo sviluppo dell’agricoltura.
__________________________________________
Verdi imprenditore agricolo
Nell’aprile 1844, grazie ai proventi dell’Ernani, opera andata in scena un mese prima alla Fenice di Venezia, Giuseppe Verdi decise di acquistare la possessione Pulgaro a Roncole di Busseto. Il maestro aveva trentun anni, il suo nome era già parecchio noto anche all’estero – non solo ai cultori musicali –, il curriculum contava titoli come Oberto conte di San Bonifacio, Un giorno di regno, Nabucco e I Lombardi alla prima crociata.
La scelta del podere, di circa ventiquattro ettari, cadde nella zona della sua “pianuraccia”. Joseph Fortunin François Verdi, figlio di Carlo e Luigia Uttini, era infatti venuto alla luce il 10 ottobre 1813 proprio a Roncole e a quella terra, generosa sì ma non sempre di facile resa, Verdi legherà le vicende della sua lunga esistenza. Una terra che era al contempo fonte di investimento, strumento di legittimazione sociale, ma anche via di ricongiungimento con i luoghi di nascita, come ebbe modo di dire al giornalista tedesco von Winterfeld in visita a Sant’Agata nel 1883 (Conati, 1980):
“Quando mi arrise la fortuna e fui in grado di mettere su casa nelle più belle zone della mia patria, acquistai questo terreno allora trascurato e deserto, sul quale tutto era brutta natura, perché situato nelle mie vicinanze del luogo di nascita e della città in cui trascorsi i miei anni giovanili, esso possedeva per me il fascino natio e mi o riva spazio per il mio bisogno di operare”.
Dopo qualche anno, grazie ai proventi di altre opere, Verdi permutò Pulgaro con la tenuta di Sant’Agata, posta nel comune di Villanova d’Arda, destinata a divenire sua dimora abituale nei mesi primaverili ed estivi (in inverno dimorava a Genova). Questo complesso, significativo esempio di “dimora di delizia” piuttosto di uso nella pianura emiliana, si trasformò gradualmente in un’azienda-corte, cuore di un complesso di possessioni distese tra il Po, l’Arda e l’Ongina. Nella terra, che era «il mio deserto e il mio cielo», la «bicocca decentemente abitabile» divenne di fatto una bella villa, con un magni co giardino. Verdi infatti dimostrò da subito una grande passione per il giardinaggio. Ordinò molte piante e ori, anche esotici, allo stabilimento Burdin Maggiore di Milano, fondato da una dinastia di vivaisti piemontesi, e più tardi divenne un ottimo cliente dei fratelli Ingegnoli.
È proprio da Sant’Agata che iniziò il percorso di Verdi imprenditore agricolo (Cenzato, 1949):
“Ampliò quella che era la rustica casa colonica, la abbellì, si trasformò in architetto. Badò soprattutto a crearle intorno un parco, una grande aureola verde, che doveva essere il suo lusso e che si ingigantì con la sua gloria. Dietro a Sant’Agata venne l’acquisto dei fondi, l’onesta ma vigile speculazione, l’impiego sapiente dei soldi che venivano sempre più copiosi. Ecco come Verdi che minacciava di essere un parigino divenne l’agricoltore”.
Dal 1851 al 1891 Verdi continuò ad acquistare, sia pure con periodicità discontinua, appezzamenti e complessi, divenendo un facoltoso possidente terriero. Gli acquisti di Pulgaro e di Sant’Agata costituirono infatti la prima tappa di un percorso di ascesa sociale e patrimoniale che permisero al Maestro di acquisire lo status di grande proprietario terriero, titolare di una miriade di piccoli e grandi poderi estesi su oltre 700 ettari, siti nei comuni di Villanova, Fiorenzuola, Cortemaggiore, Besenzone, Busseto e Gerre del Sole nel Cremonese (Phillips-Matz, 1992; Cafasi, 1994; Chini, 2013). Sono diversi i criteri e le valutazioni che mossero Verdi nell’acquisto della terra: dall’accorpamento dei fondi finitimi alla stima dell’assetto idrico, dalla resa produttiva degli appezzamenti alla presenza di vigne di qualità. Grandi tenute (Sant’Agata, di 107 ettari, Piantadoro di 207 ettari, acquistato nel 1854 e Castellazzo di 213 comprato nel 1875, tutti nel comune di Villanova), ma anche medi e piccoli poderi formarono il complesso delle “terre verdiane”, la “pianuraccia” appunto, come la definiva lo stesso Verdi. Al con ne nord-orientale tra Parma e Piacenza, segnata dalla diffusione della piccola e media proprietà, dalla prevalenza della produzione granaria e da una buona rete di comunicazioni stradali, la zona “verdiana” si presentava con un carattere fortemente parcellizzato, con pochi terreni aventi un’estensione superiore ai cento ettari. Il paesaggio tipico, costruito e disegnato dal lavoro paziente e tenace dell’uomo, era quindi per lo più dominio della piccola e media proprietà locale, caratterizzato dalla quasi uniforme destinazione ad aratorio, il cui prodotto era destinato in parte all’autoconsumo, in parte al mercato locale (Spigaroli, 1996).
Quelle terre Verdi, cresciuto in una famiglia di piccoli proprietari terrieri e locandieri, le conosceva bene perché lì aveva trascorso la sua infanzia e giovinezza. A Roncole Carlo Verdi e Luigia Uttini, avevano avviato, alla ne del Settecento, una bottega, ove la gente dei dintorni, specialmente la domenica, andava ad acquistare farina, zucchero, liquori, sale e tabacco. Una sorta di spaccio-osteria dove, oltre a zucchero e farina, circolavano le informazioni. In questo modesto locale passavano e si incontravano, discutendo di raccolti e di mercati, contadini, fattori, allevatori artigiani, piccoli proprietari e mediatori. Qui il giovane Verdi maturò anche una certa dimestichezza con i libri contabili, affinando di certo la capacità di “far di conto” e di “contrattare” con le persone. Acquisendo tante terre, divenne un proprietario attento e scrupoloso, esigente nei confronti dei suoi agenti rurali e dei suoi lavoratori, ai quali non risparmiava certo strigliate di ogni sorta. Quando era a Sant’Agata trascorreva le «giornate di a ari, di cifre, di conti con contadini e pastori», in giro per campi, caselli e mulini. Fattori, mezzadri, famiglie coloniche e lavoratori stagionali popolavano il suo universo, un piccolo microcosmo autosufficiente sì, ma aperto al commercio. Nelle possessioni verdiane si coltivava e si vendeva di tutto: il grano e la melica, il prato (erba medica e trifoglio), l’uva e il vino, i bozzoli, il legno dei boschi rivieraschi, i prodotti dell’orto. Molto importanti erano le entrate derivate dalla bachicoltura, dalla coltivazione dell’uva, dalla vendita dei prodotti dell’orto e dalla piantagione di pioppi nel- le zone rivierasche. L’economia poderale delle possessioni era a orientamento cerealicolo-zootecnico, con la presenza rimarchevole di bestiame bovino, necessario sia per il lavoro nei campi, sia per la produzione di carne e di latte.
Con qualche idea innovativa e un’esperienza che si accresceva di mano in mano, Verdi, pur senza modi care sostanzialmente l’ordinamento produttivo di quelle terre, volle perseguire un miglioramento delle rese produttive. Agronomo autodidatta, cercò di perfezionare l’assetto idrico (quanti sforzi per la tenuta degli argini!), costruì nuovi fabbricati e introdusse il prato in rotazione: molto fu l’impegno profuso dal maestro per la messa a coltura di nuove terre e per una riorganizzazione del sistema aziendale, a partire dagli edifici destinati alla produzione (stalle in particolare). Con un occhio ai progressi agricoli provenienti dalla Francia e dall’Inghilterra, Verdi, tra un’opera e l’altra, visitò anche alcune tenute italiane particolarmente all’avanguardia, come quella di Leri, nel Vercellese, di proprietà dell’amico Camillo Benso di Cavour. Ma mostrò anche attenzione per la situazione sociale delle campagne e per il grave problema dell’emigrazione. E, non ultimo, ci fu nel Maestro una grande sensibilità nei confronti delle esigenze dell’agricoltura reale come si legge in una lettera scritta il 21 ottobre 1891 al Giornale genovese «Il Caffaro» di Genova:
“Ma poiché ella mi parla d’agricoltura, di cui io non sono che un semplice dilettante, io vorrei che questa nobilissima scienza fosse maggiormente coltivata da noi. Quale fonte di ricchezza per la nostra patria! Un po’ meno di musicisti, di avvocati, di medici, e un po’ più di agricoltori: ecco il voto che faccio per mio paese”.
La biblioteca di Sant’Agata era ricca di titoli inerenti il giardinaggio e l’agricoltura. La passione per i ori e per le piante ornamentali lo portarono a leggere diversi manuali francesi (Louis François Du Bois, Nouvelle pratique simpli ée du jardinage, à l’usage des personnes qui cultivent elles-mêmes un petit domaine, Paris, Libraire encyclopedique de Roret, 1846 e Vilmorin-An-drieux, Les eurs de pleine terre comprenant la description et la culture des eurs annuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre, Paris, chez Vilmorin-Andrieux & C.ie, 1863). Di provenienza francese erano anche i testi dedicati a un’altra grande passione di Verdi: la coltivazione dell’uva e la produzione di vino. Ma accanto al celebre manuale in due tomi Traitè theorique et pratique sur la culture de la vigne, avec l’art de faire le vin, les eaux-de-vie, esprit-de-vin, vinaigres simples et composes di Rozier, Parmentier e Chaptal, edito a Parigi da Delalain, troviamo anche L’arte di fare il vino insegnata ai cantinieri di Ottavio Ottavi (Casale Monferrato, Tipografia sociale del Monferrato, 1876) Eureka!Eureka! Nuovo metodo per fare frutti care abbondantemente le viti anche in anni sfavorevoli (Casale Monferrato, 1878). Nella biblioteca agricola di Sant’Agata figuravano anche diversi testi di Giuseppe Antonio Ottavi, al quale Verdi si rivolse direttamente per avere alcune pubblicazioni. Ottavi (1818-1885), professore di agraria a Casale Monferrato, fu uno dei più noti propagandisti agrari della seconda metà dell’Ottocento, spesso anche a Piacenza per tenere alcune conferenze agrarie. Il suo testo più famoso, I segreti di don Rebo, uscì in nove edizioni dal 1853 al 1889 (Verdi ebbe la prima edizione).
L’ascesa patrimoniale di Verdi e l’organizzazione agronomica delle sue possessioni ben si inquadrano nel contesto dello sviluppo dell’agricoltura piacentina tra Otto e Novecento. La storia agraria di Verdi incrociò, per tanti aspetti, le vicende dell’agricoltura locale. Al momento dell’unificazione una generale arretratezza contraddistingueva infatti le campagne di questa zona. Il contesto era quello di un ordinamento policolturale, caratterizzato oltre che da un’intesa consociazione tra le piante erbacee, dalla forte promiscuità di quest’ultime con le colture arboree e arbustive. A partire dagli anni ottanta dell’Ottocento, e grazie allo spirito di intraprendenza della moderna borghesia terriera, si avviò, nelle terre di pianura, un processo di specializzazione agraria, segnato dallo sviluppo dell’allevamento bovino, dal miglioramento delle rese granarie, dall’introduzione di nuove attrezzature e da un’e cace integrazione tra agricoltura, industria e propaganda agraria. All’inizio del nuovo secolo, oltre a uno straordinario ammodernamento del settore primario, si registrerà poi un primo decollo di quei settori, basati per lo più sull’interconnessione con l’industria, che diverranno poi tipici dell’industria agro-alimentare piacentina e parmense. Il graduale progresso, uscito da due decenni di crisi agraria, si concretizzò in terra emiliana in tre direzioni: l’allevamento integrato bovino-suino che, con il ciclo della lavorazione del latte, portò la produzione casearia ai massimi livelli; il settore conserviero che integrò stabilmente la produzione dei campi alla produzione delle fabbriche di pomodoro, la coltivazione della barbabietola da zucchero e l’impianto degli zuccheri ci. L’introduzione di produzioni specializzate ad alto valore aggiunto rimodellò, agli inizi del Novecento, il paesaggio ereditato dal passato, condizionando la magliatura del nuovo spazio organizzato. Mentre in collina le moderne cantine divennero il simbolo della centralità della vite, in pianura le stalle, i caselli e le fabbriche di pomodoro e di zucchero si configuravano come segni tangibili di un nuovo sistema specializzato per prodotto. Anche nelle terre verdiane cambiò rapidamente il paesaggio antropologico ed economico: furono le nuove stalle e i caselli/caseifici a segnare anche visivamente il passaggio a una nuova agricoltura. I poderi di questa area, avviati decisamente verso l’allevamento e la produzione lattiero-casearaia, iniziarono così a orientare la loro dimensione in funzione delle colture pratensi, anche se la cerealicoltura restava di fatto l’asse portante del sistema agrario.
L’innovazione nelle campagne piacentine e parmensi passò attraverso l’azione di tecniche in grado di avviare un procedimento di diversificazione colturale, adatta alle differenti vocazioni ambientali e al nuovo andamento dei mercati sul piano della domanda. Interpreti di questo nuovo atteggiamento furono i membri di quella élite agraria, composta per la maggior parte di possidenti che, alla guida delle aziende agricole di famiglia, cercano di adeguarne la produzione alle esigenze di mercato, facendo dell’agricoltura uno strumento di accrescimento e di consolidamento dei patrimoni familiari, con scelte produttive orientate alla massimizzazione del prodotto (Banti, 1989). Questa classe agraria, capace di mettere in atto forme di sfruttamento della terra di tipo lombardo e di mostrarsi all’avanguardia nella creazione di strumenti organizzativi del padronato e dell’imprenditoria, sarà protagonista di alcune delle più importanti esperienze di interconnessione tra agricoltura e industria della trasformazione dei prodotti agricoli. Verdi ebbe modo di conoscere bene alcuni di questi protagonisti e di mutuare, per certi aspetti, la loro esperienza. Il Maestro fu amico e in corrispondenza con diversi agricoltori piacentini. Tra questi, Luigi Zangrandi, medico, direttore dell’Ospedale di Piacenza, fondatore, nel 1862, del Comizio agrario, il quale, nella sua proprietà di Mercore di Besenzone, creò un grande magazzino di attrezzi agricoli. Verdi intrattenne inoltre cordiali rapporti di amicizia con diversi membri della famiglia Fioruzzi, proprietari di estesi pos- sedimenti alle porte di Piacenza: Carlo, che fu anche suo avvocato, Ulisse e Attilio, provetti costruttori meccanici, ed Emilio, attivo sostenitore della specializzazione zootecnica.
Oltre al reticolo di amicizie, l’accoglimento e la trasmissione dell’innovazione agraria passava allora attraverso diversi altri canali, quali la frequentazione di mercati ed esposizioni. Il Maestro non disdegnava di recarsi presso i mercati della zona, come quelli di Fiorenzuola a Borgo San Donnino. Non solo, ma la visita di fiere agricole, molto numerose a quell’epoca, permise a Verdi di prendere visione delle novità agrarie, soprattutto nel settore della meccanica e degli aratri in particolare, per i quali nutriva una vera passione.
Giuseppe Verdi amava molto scrivere. Nelle lettere, con gli agenti rurali in primis, ma anche con gli amici, discuteva di condizioni del tempo, di alleva- mento, di prezzi delle granaglie, del vino e del bestiame. Tra gli epistolari più significativi troviamo quello con il conte e giornalista mantovano Opprandino Arrivabene, al quale spesso descriveva la sua vita in campagna, segnata da molteplici impegni. Nelle possessioni verdiane c’era infatti sempre un gran fermento. Non poteva essere altrimenti, dal momento che il Maestro ci teneva a fare il contadino, ma anche il magut (il muratore), senza mai dimenticare di essere il “direttore” dei suoi operai (Alberti, 1931).
“Caro Arrivabene, il maestro Verdi si trova o sulla ferrovia di Genova o in un pozzo a Sant’Agata. Mi spiego. Questo predetto signor maestro gli è venuto in testa di far costruire una macchina a vapore per estrarre acqua da un torrentello che scorre presso la sua casa: per ottenere l’intento gli è d’uopo di un condotto sotto terra alla profondità di sei metri della lunghezza di 25: più un pozzo profondo quasi 7 metri. A quella profondità si trova una massa abbondante di acqua e sabbia che rende il lavoro murario estremamente difficile. Il prelodato maestro trovasi tutto il giorno là in fondo un po’ per incoraggiare i lavoranti, un po’ per strapazzarli e soprattutto per dirigerli. Dirigerli?!!!! È questo il debole del signor maestro. Se tu gli dici che il Don Carlos non val niente non gliene importa un fico, ma se tu gli contrasti la sua abilità nel fare il magut, se n’ha a male”.
La fama di Verdi come agricoltore – e non solo come compositore – iniziò a diffondersi presto anche all’estero. Nel 1887 lo scrittore e giornalista scozzese Samuel Smiles parlò di Verdi nell’opera Vita e lavoro: studio sugli uomini insigni per operosità, cultura e ingegno, tradotta in Italia l’anno successivo dalla casa editrice Barbera.
L’occupazione prediletta del grande compositore Verdi, che di recente, all’età di 73 anni ha meravigliato il mondo colla sua opera Otello, fu un tempo quella abbastanza prosaica di fare il fattore. S’intendeva di raccolti e di bestiame quanto di contrappunto e di basso numerato. I fattori dei dintorni della sua villa di Sant’Agata lo consideravano come un’autorità in materia di coltivazione del terreno e lo consultavano sulla rotazione della semente e sull’allevamento del bestiame.
Qualche anno prima, nel 1883, buona parte dell’intervista rilasciata al giornalista tedesco von Winterfeld in visita a Sant’Agata venne dedicata alla ricostruzione del suo percorso agrario:
Non pensate che io qui abbia trovato tutto in ordine come lo vedete adesso. È tutto fatiche di anni. Risiedere in un podere bene ordinato o in una graziosa villa mi sarebbe piaciuto poco. Prima questi campi dovevano essere coltivati, i frutteti piantati, la mia casa e i miei granai costruiti e il mio parco, allora una macchia incolta, creato.
Alla morte, avvenuta il 27 gennaio 1901, anche il mondo agrario piacen- tino rese omaggio al Maestro. Il «Giornale di agricoltura della domenica», organo della Federconsorzi diretto da Giovanni Raineri, gli dedicò una bella prima pagina, ricordando il suo impegno a favore dei lavoratori della terra e la volontà testamentaria di istituire due borse di studio a favore di studenti di agraria residenti nella zona.
Daniela Morsia
Dagli atti della Giornata di studio “Giuseppe Verdi Agricoltore”, Accademia dei Georgofili, Firenze, 29 aprile 2014
Daniela Morsia - Biblioteca comunale Passerini-Landi, Piacenza